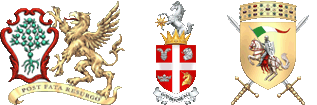Insegne in Valdinievole
Moderatori: mcs, Antonio Pompili
11 messaggi
• Pagina 1 di 1
Insegne in Valdinievole
Buonasera, durante le mie passeggiate nei borghi della Valdinievole mi sono imbattuta in alcune insegne di pietra di cui mi piacerebbe conoscere le origini. Potete aiutarmi?
1)
1)
- BrunaR
- Messaggi: 19
- Iscritto il: martedì 14 aprile 2009, 21:21
Re: Insegne in Valdinievole
Mi ha colpito la corona nello stemma di questa famiglia toscana
Titoli e corone come si sa sono fortunatamente inusuali in Toscana e denotano immediatamente tempi vicini a noi
Io ho le mie idee sulla nobilta'
ho sempre pensato che storicamente la base della nobilta' e' la vicinanza col potere e la ricchezza
Questo esempio di tardo arricchimento e nobilitazione conseguente e' una storia utile a comprendere meglio i tempi
Vi troviamo anche la tratta degli schiavi, anche questo senza meraviglia, perche' specchio del periodo , e quindi normale
by archivio SIUSA
La famiglia Feroni ha origine da una diramazione della famiglia Baldacci di Vinci; tra la fine del Cinquecento e i primi anni del Seicento, Paolo Baldacci e suo figlio Baldo assumono progressivamente il cognome Feroni derivato verosimilmente dal nome di Ferone Baldacci, padre di Paolo. Baldo Feroni si insedia con la famiglia ad Empoli e avvia una bottega di tintoria; forse è proprio a Baldo che va assegnato un primo tentativo di ascesa sociale della famiglia. Con pratica comune il Feroni avvia uno dei figli (Paolo) alla carriera militare, un altro (Tommaso) a quella ecclesiastica e affianca a sé il figlio Francesco nell’attività di tintore, alla quale si unisce presto quella di mercante.
È comunque a Francesco Feroni (1614 - 1696) che si deve l’inizio delle fortune della famiglia; entrato in contatto con il senatore e mercante fiorentino Lorenzo Buonaccorsi (con il quale in seguito si apre un feroce contenzioso) Francesco si stabilisce prima a Livorno e poi si trasferisce, nella prima metà degli anni ‘40 del Seicento, ad Amsterdam incrementando i propri investimenti e specializzandosi nel commercio di cereali. Verso l’inizio del decennio successivo il Feroni sposa Prudenza, figlia di Silvio Tensini (un mercante di cereali russi originario di Crema, ma insediatosi da tempo ad Anversa), saldando così i suoi legami con il mondo dei ricchi mercanti italiani emigrati nel nord Europa. Contemporaneamente amplia i propri orizzonti commerciali impegnandosi sulla piazza di Lisbona, rendendosi mediatore dell’esportazione di zucchero brasiliano, spezie e tessuti, e impegnandosi nella tratta degli schiavi. Il prestigio che il toscano acquisisce ad Amsterdam induce il granduca Ferdinando II ad incaricare Francesco, prima in via ufficiosa - durante la guerra anglo-olandese (1652-1654) - e poi in via ufficiale (dal 1666), di agire come rappresentante degli interessi medicei presso le Provincie Unite; in queste occasioni il Feroni dimostra, a quanto pare, una certa sfrontatezza, un notevole acume e uno spirito di iniziativa che incuriosiscono ancora di più la corte medicea. I legami con la Corte granducale si saldano definitivamente quando Francesco Feroni ospita tra il dicembre del 1667 e il gennaio del 1668 il gran principe Cosimo (futuro granduca col nome di Cosimo III) durante il suo viaggio in incognito per l’Europa. In questa occasione il mercante arriva ad impegnarsi per anticipare in proprio le spese del principe di casa Medici.
L’intensificazione dei contatti con la Corte coinvolge il Feroni nel nuovo ruolo di intermediario per il commercio di oggetti suntuari e di opere d’arte, ma pone soprattutto le basi per la progettazione di un rientro in patria. Inizia così un estenuante periodo di trattative per l’investimento del proprio capitale nell’acquisto di una vasta tenuta agricola in Toscana. L’invasione francese dell’Olanda e il raggiunto accordo per la vendita della fattoria medicea di Bellavista in Valdinevole, con possibilità di erezione in contea o marchesato, inducono il Feroni ad abbandonare di nascosto Amsterdam una sera di febbraio del 1673.
Rientrato in Toscana, stabilitosi a Firenze e ottenutane la cittadinanza per concessione granducale, Francesco chiude finalmente il contratto per l’acquisto della tenuta di Bellavista il 27 settembre 1673. Qualche anno dopo (1676) si installa nel cinquecentesco palazzo Zanchini, posto nella prestigiosa via Maggio in Oltrarno (via nella quale qualche anno prima si sistema anche il fratello di Francesco, il capitano Paolo Feroni; si veda n. 242.12, n. 242.20). Qui, e in alcune case adiacenti prese in affitto, la famiglia risiede fino agli acquisti del palazzo Spini di Santa Trinita ad opera del marchese Antonio Francesco e del palazzo di S. Frediano ad opera del marchese Francesco Giuseppe (entrambi gli edifici acquistati dopo il 1764).
Segue serrata l’ascesa politica del mercante che nel 1674 ottiene la nomina a senatore e Depositario generale, l’anno successivo entra nella Deputazione per le riforme dei Magistrati e in seguito viene incaricato della soprintendenza della Magona del ferro e dello Scrittoio delle possessioni e della Guardaroba generale (1682). Nel 1681 arriva l’agognata investitura feudale con titolo marchionale della fattoria di Bellavista, due anni dopo il primogenito Fabio sposa Costanza Lotteringhi della Stufa - rappresentante di una famiglia fiorentina di antica nobiltà - nel contempo si progettano i matrimoni delle figlie di Francesco in casa Vecchietti e in casa Portinari e si pongono le basi per la carriera ecclesiastica del cadetto Silvio Feroni, che si rivela però fallimentare. Per sancire il prestigio raggiunto e perpetuare la propria memoria Francesco non si impegna nell’acquistare o costruire un grande palazzo in città, ma decide di occuparsi della propria sepoltura: appena giunto in Firenze (1673) si interessa di una cappella in S. Maria Maggiore (parrocchiale della sua prima abitazione cittadina), indirizza poi (1680) la sua attenzione sulla rinomata cappella Brancacci al Carmine per ottenere infine nel 1691 il patronato della cappella di S. Giuliano alla SS. Annunziata. Quest’ultima viene dedicata dal Feroni a S. Giuseppe e trasformata in un suntuosissimo ambiente dopo una campagna triennale di restauri ad opera del gruppo di artisti più in voga presso la corte medicea.
Il marchese Francesco Feroni muore nella villa di Montughi il 17 gennaio 1696 dopo avere dettato un definitivo testamento - sono otto le differenti versioni di ultime volontà che il Feroni fece rogare tra il 1684 e il 1695 - che vincola la sua eredità in due fidecommessi, uno relativo alla linea di primogenitura e l’altro relativo alla linea di secondogenitura.
Il secondo marchese di Bellavista, Fabio Feroni (1674?-1702), eredita in parte le cariche paterne e prosegue il progetto di inserimento della casata tra la nobiltà fiorentina. Ancora prima della morte del padre intraprende una campagna di lavori nella tenuta di Bellavista, volti ad affiancare all’antica fattoria medicea un vero e proprio palazzo. Sotto la direzione dell’architetto Antonio Ferri nasce così il complesso di villa, fattoria e cappella, con i giardini all’italiana e il vasto parco. Fabio muore il 31 ottobre del 1702 lasciando i figli minori Francesco, Ubaldo, Giuseppe Maria e Alessandro sotto la tutela della moglie Costanza Lotteringhi della Stufa, del fratello Silvio e dei cognati.
Francesco (1687-1764), terzo marchese di Bellavista, figlio di Fabio, sposa Matilde Malaspina e venne insignito del cavalierato dell’Ordine di S. Stefano. Ubaldo (1689-1761), dapprima abate, lascia la vita religiosa e prosegue per qualche tempo la tradizione mercantile della famiglia risiedendo in Milano e a Venezia; in quest’ultima città contrae matrimonio con Fiorelisa Salomon. Giuseppe Maria (1693 aprile 30-1767 novembre 15) si trasferisce a Roma e persegue una discreta carriera ecclesiastica; cresciuta all’ombra del potente partito fiorentino presente alla Corte pontificia la sua ascesa culmina con la nomina al cardinalato avvenuta nel 1753. Il cardinale sembra interessarsi attivamente degli interessi famigliari, specie a quelli patrimoniali, mantiene legami stretti soprattutto con il fratello Ubaldo e riesce a strappare al Pontefice la cessione in enfiteusi perpetua dei beni della celebre abbazia di S. Galgano (1743 e 1757), della quale è abate commendatario dal 1723, per i propri nipoti.
Gli anni che seguono la morte del secondo marchese sono comunque anni di incertezze per il patrimonio famigliare dei Feroni: la divisione dei beni tra i figli di Fabio, nel rispetto delle disposizioni testamentarie del senatore Francesco Feroni, diviene oggetto di notevoli contenziosi. Francesco, primogenito di Fabio, contesta l’amministrazione della madre e appena uscito da tutela avvia un procedimento per la divisione delle sostanze paterne. Con il tempo i dissapori nati da questa divisione si acuiscono, prima in occasione della morte di Silvio Feroni nel 1733, zio del marchese, e successivamente a seguito delle polemiche inerenti la tutela di Alessandro Feroni, incapace di intendere e di volere; le sue sostanze sono prima amministrate dalla madre e poi dal fratello Ubaldo che, a detta di Francesco, intaccano per i propri interessi il patrimonio del giovane.
Mantiene uniti i fratelli Feroni solo l’accesa controversia nata a seguito dell’emanazione della legge sul patriziato (1750 ottobre 1); l’istanza dei membri di casa Feroni per essere ammessi al patriziato fiorentino viene inizialmente respinta a causa della mancanza di “generosa nobiltà” (ovvero nobiltà superiore ai duecento anni) e tutte le insofferenze dei componenti delle più antiche famiglie fiorentine contro i Feroni vengono a galla. Il cambiamento di regime, causato dall’estinzione della dinastia medicea, pone inoltre i Feroni in un rapporto completamente diverso con la nuova corte degli Asburgo Lorena. Questi trovano infatti poche simpatie nel Consiglio di Reggenza: i fratelli si appellano a Vienna e fanno quadrato sfruttando tutte le possibili aderenze per indurre Francesco Stefano di Lorena ad esprimere un responso favorevole.
La morte di Alessandro (1757 marzo 8) riapre la decennale causa intrapresa dai fratelli Feroni che vede contrapporsi Francesco, accompagnato dal figlio Antonio Francesco, e Ubaldo, sostenuto dal fratello cardinale. Le pretese donazioni che Ubaldo ha estorto al fratello Alessandro vengono annullate, ma le sentenze non esauriscono le polemiche relative alla spartizione di alcuni beni comuni e all’asse ereditario vincolato dal fidecommesso di secondogenitura; solo le morti di Francesco (1764) e di suo figlio Antonio Francesco (1769) ridefiniscono l’assetto della situazione patrimoniale della famiglia. Antonio Francesco muore infatti senza eredi maschi e le figlie ripudiano un’eredità fortemente gravata da debiti; acquietati i creditori, quanto rimasto del patrimonio di Antonio Francesco (la tenuta di Bellavista, il palazzo Spini di Santa Trinita, le quote già appartenute ad Alessandro della villa di Pian di Ripoli e dei poderi di S. Giovanni Valdarno) ritorna in casa Feroni passando a Francesco Giuseppe (1739-1786), figlio di Ubaldo, quinto marchese di Bellavista.
Nel contempo il patrimonio famigliare è messo a dura prova anche dai lavori approntati nella tenuta di Bellavista: già il marchese Fabio, ma successivamente anche Francesco, assistito dallo zio Silvio, intraprendono grandi opere di bonifica dell’area del Padule di Fucecchio spettante alla fattoria. Le bonifiche non sempre sortiscono gli effetti sperati, anzi finiscono con rendere insalubri vari poderi siti poco distanti dalla villa e contribuiscono ad aprire svariate cause con lo Scrittoio delle possessioni (l’ufficio posto a tutela dei beni camerali della famiglia Medici) e con altri confinanti della tenuta di Bellavista. Un’epidemia scoppiata tra il 1756 e il 1757 in Valdinievole richiama l’attenzione del governo lorenese sullo stato delle campagne del bacino del Padule. Nuove bonifiche vengono quindi programmate secondo un piano generale imposto dal Governo al quale si adeguano le generazioni successive di casa Feroni. Nonostante questi dispendiosi interventi le rendite della fattoria non subiscono sostanziali incrementi e i poderi vengono progressivamente venduti dai marchesi Francesco Ubaldo e Fabio Feroni, figli di Francesco Giuseppe. Nel 1829 viene venduta la villa di Bellavista e negli stessi anni ceduti i due palazzi di città, nel 1821 il palazzo in S. Frediano di via Serragli e nel 1834 quello di S. Trinita. Al marchese Leopoldo (1773-1852), altro figlio di Francesco Giuseppe, spettano invece la maggior parte dei beni dell’abbazia di S. Galgano e la villa di Frosini. Letterato e poeta il marchese si occupa di ristrutturare la tenuta, ma anche di tenere viva la memoria dell’antica abbazia ormai in rovina pubblicando nel 1835 in Firenze un Compendio della vita di S. Galgano. In città Leopoldo acquista il palazzo Sassi della Tosa in via della Stipa dove viene esposta e parzialmente aperta al pubblico una parte dell’antica quadreria ereditata dal padre Francesco Giuseppe. Alla sua morte, avvenuta nel 1852, parte della collezione di quadri viene venduta da Paolo Feroni (1807-1864), nipote di Leopoldo, patriota, pittore e direttore della Galleria degli Uffizi, mentre ciò che ne rimane è donato da Alessandro (1799-1865), fratello di Paolo, alla città di Firenze nel 1865, in parziale adempimento delle volontà di Leopoldo Feroni.
Con Alessandro Feroni si estingue la linea maschile della casata; sua figlia Giulia sposa Costantino Cerrina, discendente di una casata piemontese avviata alla carriera militare. Nel 1902 Costantino Cerrina ottiene di aggiungere al proprio il cognome della moglie, mentre con un diploma datato 11 novembre 1914 acquisisce il diritto di insignirsi del titolo marchionale, senza predicato, trasmissibile in linea maschile.
Titoli e corone come si sa sono fortunatamente inusuali in Toscana e denotano immediatamente tempi vicini a noi
Io ho le mie idee sulla nobilta'
ho sempre pensato che storicamente la base della nobilta' e' la vicinanza col potere e la ricchezza
Questo esempio di tardo arricchimento e nobilitazione conseguente e' una storia utile a comprendere meglio i tempi
Vi troviamo anche la tratta degli schiavi, anche questo senza meraviglia, perche' specchio del periodo , e quindi normale
by archivio SIUSA
La famiglia Feroni ha origine da una diramazione della famiglia Baldacci di Vinci; tra la fine del Cinquecento e i primi anni del Seicento, Paolo Baldacci e suo figlio Baldo assumono progressivamente il cognome Feroni derivato verosimilmente dal nome di Ferone Baldacci, padre di Paolo. Baldo Feroni si insedia con la famiglia ad Empoli e avvia una bottega di tintoria; forse è proprio a Baldo che va assegnato un primo tentativo di ascesa sociale della famiglia. Con pratica comune il Feroni avvia uno dei figli (Paolo) alla carriera militare, un altro (Tommaso) a quella ecclesiastica e affianca a sé il figlio Francesco nell’attività di tintore, alla quale si unisce presto quella di mercante.
È comunque a Francesco Feroni (1614 - 1696) che si deve l’inizio delle fortune della famiglia; entrato in contatto con il senatore e mercante fiorentino Lorenzo Buonaccorsi (con il quale in seguito si apre un feroce contenzioso) Francesco si stabilisce prima a Livorno e poi si trasferisce, nella prima metà degli anni ‘40 del Seicento, ad Amsterdam incrementando i propri investimenti e specializzandosi nel commercio di cereali. Verso l’inizio del decennio successivo il Feroni sposa Prudenza, figlia di Silvio Tensini (un mercante di cereali russi originario di Crema, ma insediatosi da tempo ad Anversa), saldando così i suoi legami con il mondo dei ricchi mercanti italiani emigrati nel nord Europa. Contemporaneamente amplia i propri orizzonti commerciali impegnandosi sulla piazza di Lisbona, rendendosi mediatore dell’esportazione di zucchero brasiliano, spezie e tessuti, e impegnandosi nella tratta degli schiavi. Il prestigio che il toscano acquisisce ad Amsterdam induce il granduca Ferdinando II ad incaricare Francesco, prima in via ufficiosa - durante la guerra anglo-olandese (1652-1654) - e poi in via ufficiale (dal 1666), di agire come rappresentante degli interessi medicei presso le Provincie Unite; in queste occasioni il Feroni dimostra, a quanto pare, una certa sfrontatezza, un notevole acume e uno spirito di iniziativa che incuriosiscono ancora di più la corte medicea. I legami con la Corte granducale si saldano definitivamente quando Francesco Feroni ospita tra il dicembre del 1667 e il gennaio del 1668 il gran principe Cosimo (futuro granduca col nome di Cosimo III) durante il suo viaggio in incognito per l’Europa. In questa occasione il mercante arriva ad impegnarsi per anticipare in proprio le spese del principe di casa Medici.
L’intensificazione dei contatti con la Corte coinvolge il Feroni nel nuovo ruolo di intermediario per il commercio di oggetti suntuari e di opere d’arte, ma pone soprattutto le basi per la progettazione di un rientro in patria. Inizia così un estenuante periodo di trattative per l’investimento del proprio capitale nell’acquisto di una vasta tenuta agricola in Toscana. L’invasione francese dell’Olanda e il raggiunto accordo per la vendita della fattoria medicea di Bellavista in Valdinevole, con possibilità di erezione in contea o marchesato, inducono il Feroni ad abbandonare di nascosto Amsterdam una sera di febbraio del 1673.
Rientrato in Toscana, stabilitosi a Firenze e ottenutane la cittadinanza per concessione granducale, Francesco chiude finalmente il contratto per l’acquisto della tenuta di Bellavista il 27 settembre 1673. Qualche anno dopo (1676) si installa nel cinquecentesco palazzo Zanchini, posto nella prestigiosa via Maggio in Oltrarno (via nella quale qualche anno prima si sistema anche il fratello di Francesco, il capitano Paolo Feroni; si veda n. 242.12, n. 242.20). Qui, e in alcune case adiacenti prese in affitto, la famiglia risiede fino agli acquisti del palazzo Spini di Santa Trinita ad opera del marchese Antonio Francesco e del palazzo di S. Frediano ad opera del marchese Francesco Giuseppe (entrambi gli edifici acquistati dopo il 1764).
Segue serrata l’ascesa politica del mercante che nel 1674 ottiene la nomina a senatore e Depositario generale, l’anno successivo entra nella Deputazione per le riforme dei Magistrati e in seguito viene incaricato della soprintendenza della Magona del ferro e dello Scrittoio delle possessioni e della Guardaroba generale (1682). Nel 1681 arriva l’agognata investitura feudale con titolo marchionale della fattoria di Bellavista, due anni dopo il primogenito Fabio sposa Costanza Lotteringhi della Stufa - rappresentante di una famiglia fiorentina di antica nobiltà - nel contempo si progettano i matrimoni delle figlie di Francesco in casa Vecchietti e in casa Portinari e si pongono le basi per la carriera ecclesiastica del cadetto Silvio Feroni, che si rivela però fallimentare. Per sancire il prestigio raggiunto e perpetuare la propria memoria Francesco non si impegna nell’acquistare o costruire un grande palazzo in città, ma decide di occuparsi della propria sepoltura: appena giunto in Firenze (1673) si interessa di una cappella in S. Maria Maggiore (parrocchiale della sua prima abitazione cittadina), indirizza poi (1680) la sua attenzione sulla rinomata cappella Brancacci al Carmine per ottenere infine nel 1691 il patronato della cappella di S. Giuliano alla SS. Annunziata. Quest’ultima viene dedicata dal Feroni a S. Giuseppe e trasformata in un suntuosissimo ambiente dopo una campagna triennale di restauri ad opera del gruppo di artisti più in voga presso la corte medicea.
Il marchese Francesco Feroni muore nella villa di Montughi il 17 gennaio 1696 dopo avere dettato un definitivo testamento - sono otto le differenti versioni di ultime volontà che il Feroni fece rogare tra il 1684 e il 1695 - che vincola la sua eredità in due fidecommessi, uno relativo alla linea di primogenitura e l’altro relativo alla linea di secondogenitura.
Il secondo marchese di Bellavista, Fabio Feroni (1674?-1702), eredita in parte le cariche paterne e prosegue il progetto di inserimento della casata tra la nobiltà fiorentina. Ancora prima della morte del padre intraprende una campagna di lavori nella tenuta di Bellavista, volti ad affiancare all’antica fattoria medicea un vero e proprio palazzo. Sotto la direzione dell’architetto Antonio Ferri nasce così il complesso di villa, fattoria e cappella, con i giardini all’italiana e il vasto parco. Fabio muore il 31 ottobre del 1702 lasciando i figli minori Francesco, Ubaldo, Giuseppe Maria e Alessandro sotto la tutela della moglie Costanza Lotteringhi della Stufa, del fratello Silvio e dei cognati.
Francesco (1687-1764), terzo marchese di Bellavista, figlio di Fabio, sposa Matilde Malaspina e venne insignito del cavalierato dell’Ordine di S. Stefano. Ubaldo (1689-1761), dapprima abate, lascia la vita religiosa e prosegue per qualche tempo la tradizione mercantile della famiglia risiedendo in Milano e a Venezia; in quest’ultima città contrae matrimonio con Fiorelisa Salomon. Giuseppe Maria (1693 aprile 30-1767 novembre 15) si trasferisce a Roma e persegue una discreta carriera ecclesiastica; cresciuta all’ombra del potente partito fiorentino presente alla Corte pontificia la sua ascesa culmina con la nomina al cardinalato avvenuta nel 1753. Il cardinale sembra interessarsi attivamente degli interessi famigliari, specie a quelli patrimoniali, mantiene legami stretti soprattutto con il fratello Ubaldo e riesce a strappare al Pontefice la cessione in enfiteusi perpetua dei beni della celebre abbazia di S. Galgano (1743 e 1757), della quale è abate commendatario dal 1723, per i propri nipoti.
Gli anni che seguono la morte del secondo marchese sono comunque anni di incertezze per il patrimonio famigliare dei Feroni: la divisione dei beni tra i figli di Fabio, nel rispetto delle disposizioni testamentarie del senatore Francesco Feroni, diviene oggetto di notevoli contenziosi. Francesco, primogenito di Fabio, contesta l’amministrazione della madre e appena uscito da tutela avvia un procedimento per la divisione delle sostanze paterne. Con il tempo i dissapori nati da questa divisione si acuiscono, prima in occasione della morte di Silvio Feroni nel 1733, zio del marchese, e successivamente a seguito delle polemiche inerenti la tutela di Alessandro Feroni, incapace di intendere e di volere; le sue sostanze sono prima amministrate dalla madre e poi dal fratello Ubaldo che, a detta di Francesco, intaccano per i propri interessi il patrimonio del giovane.
Mantiene uniti i fratelli Feroni solo l’accesa controversia nata a seguito dell’emanazione della legge sul patriziato (1750 ottobre 1); l’istanza dei membri di casa Feroni per essere ammessi al patriziato fiorentino viene inizialmente respinta a causa della mancanza di “generosa nobiltà” (ovvero nobiltà superiore ai duecento anni) e tutte le insofferenze dei componenti delle più antiche famiglie fiorentine contro i Feroni vengono a galla. Il cambiamento di regime, causato dall’estinzione della dinastia medicea, pone inoltre i Feroni in un rapporto completamente diverso con la nuova corte degli Asburgo Lorena. Questi trovano infatti poche simpatie nel Consiglio di Reggenza: i fratelli si appellano a Vienna e fanno quadrato sfruttando tutte le possibili aderenze per indurre Francesco Stefano di Lorena ad esprimere un responso favorevole.
La morte di Alessandro (1757 marzo 8) riapre la decennale causa intrapresa dai fratelli Feroni che vede contrapporsi Francesco, accompagnato dal figlio Antonio Francesco, e Ubaldo, sostenuto dal fratello cardinale. Le pretese donazioni che Ubaldo ha estorto al fratello Alessandro vengono annullate, ma le sentenze non esauriscono le polemiche relative alla spartizione di alcuni beni comuni e all’asse ereditario vincolato dal fidecommesso di secondogenitura; solo le morti di Francesco (1764) e di suo figlio Antonio Francesco (1769) ridefiniscono l’assetto della situazione patrimoniale della famiglia. Antonio Francesco muore infatti senza eredi maschi e le figlie ripudiano un’eredità fortemente gravata da debiti; acquietati i creditori, quanto rimasto del patrimonio di Antonio Francesco (la tenuta di Bellavista, il palazzo Spini di Santa Trinita, le quote già appartenute ad Alessandro della villa di Pian di Ripoli e dei poderi di S. Giovanni Valdarno) ritorna in casa Feroni passando a Francesco Giuseppe (1739-1786), figlio di Ubaldo, quinto marchese di Bellavista.
Nel contempo il patrimonio famigliare è messo a dura prova anche dai lavori approntati nella tenuta di Bellavista: già il marchese Fabio, ma successivamente anche Francesco, assistito dallo zio Silvio, intraprendono grandi opere di bonifica dell’area del Padule di Fucecchio spettante alla fattoria. Le bonifiche non sempre sortiscono gli effetti sperati, anzi finiscono con rendere insalubri vari poderi siti poco distanti dalla villa e contribuiscono ad aprire svariate cause con lo Scrittoio delle possessioni (l’ufficio posto a tutela dei beni camerali della famiglia Medici) e con altri confinanti della tenuta di Bellavista. Un’epidemia scoppiata tra il 1756 e il 1757 in Valdinievole richiama l’attenzione del governo lorenese sullo stato delle campagne del bacino del Padule. Nuove bonifiche vengono quindi programmate secondo un piano generale imposto dal Governo al quale si adeguano le generazioni successive di casa Feroni. Nonostante questi dispendiosi interventi le rendite della fattoria non subiscono sostanziali incrementi e i poderi vengono progressivamente venduti dai marchesi Francesco Ubaldo e Fabio Feroni, figli di Francesco Giuseppe. Nel 1829 viene venduta la villa di Bellavista e negli stessi anni ceduti i due palazzi di città, nel 1821 il palazzo in S. Frediano di via Serragli e nel 1834 quello di S. Trinita. Al marchese Leopoldo (1773-1852), altro figlio di Francesco Giuseppe, spettano invece la maggior parte dei beni dell’abbazia di S. Galgano e la villa di Frosini. Letterato e poeta il marchese si occupa di ristrutturare la tenuta, ma anche di tenere viva la memoria dell’antica abbazia ormai in rovina pubblicando nel 1835 in Firenze un Compendio della vita di S. Galgano. In città Leopoldo acquista il palazzo Sassi della Tosa in via della Stipa dove viene esposta e parzialmente aperta al pubblico una parte dell’antica quadreria ereditata dal padre Francesco Giuseppe. Alla sua morte, avvenuta nel 1852, parte della collezione di quadri viene venduta da Paolo Feroni (1807-1864), nipote di Leopoldo, patriota, pittore e direttore della Galleria degli Uffizi, mentre ciò che ne rimane è donato da Alessandro (1799-1865), fratello di Paolo, alla città di Firenze nel 1865, in parziale adempimento delle volontà di Leopoldo Feroni.
Con Alessandro Feroni si estingue la linea maschile della casata; sua figlia Giulia sposa Costantino Cerrina, discendente di una casata piemontese avviata alla carriera militare. Nel 1902 Costantino Cerrina ottiene di aggiungere al proprio il cognome della moglie, mentre con un diploma datato 11 novembre 1914 acquisisce il diritto di insignirsi del titolo marchionale, senza predicato, trasmissibile in linea maschile.
- pierluigic
- Messaggi: 1750
- Iscritto il: lunedì 5 settembre 2005, 22:40
- Località: la spezia >>>> pierluigi18faber@libero.it
Re: Insegne in Valdinievole
quindi
la didascalia puo' ingannare la comprensione : lo stemma in pietra con corona e' ben posteriore all'edificazione della chiesa
Questa si trova all’esterno di un edificio sacro edificato alla fine del XVI secolo, ma in parte inglobato nelle più antiche mura castellane, di origine longobarda
la didascalia puo' ingannare la comprensione : lo stemma in pietra con corona e' ben posteriore all'edificazione della chiesa
- pierluigic
- Messaggi: 1750
- Iscritto il: lunedì 5 settembre 2005, 22:40
- Località: la spezia >>>> pierluigi18faber@libero.it
Re: Insegne in Valdinievole
quindi
Questa si trova all’esterno di un edificio sacro edificato alla fine del XVI secolo, ma in parte inglobato nelle più antiche mura castellane, di origine longobarda
la didascalia puo' ingannare la comprensione : lo stemma in pietra con corona e' ben posteriore all'edificazione della chiesa
....o l'edificazione del luogo sacro va posdatato
- pierluigic
- Messaggi: 1750
- Iscritto il: lunedì 5 settembre 2005, 22:40
- Località: la spezia >>>> pierluigi18faber@libero.it
Re: Insegne in Valdinievole
Grazie infinite Pierluigi, in effetti ricordavo di aver visto quello stemma da qualche parte, ma non mi era venuta in mente la famiglia Feroni, che fu proprietaria di un vasto territorio acquistato da Cosimo III e della Villa denominata Bellavista a Buggiano. Dal momento che lo stemma della mia foto si trova presso un monastero sulla collina sovrastante la villa, posso ipotizzare che i Feroni avessero fatto delle donazioni in denaro per ristrutturare il monastero che dalla sua fondazione (XVI secolo) era stato ampliato più volte, inglobando anche la vicina chiesa. O forse le monache avevano ricevuto dai Feroni dei terreni per la realizzazione dell’orto, o anche la possibilità di dotarlo di un fontanello, attingendo l’acqua da una sorgente o pozzo dei Feroni.
Ma dal momento che alcuni rappresentanti della famiglia avevano intrapreso con discreto successo la carriera ecclesiastica, potrebbe darsi che lo stemma stesse piuttosto a significare una sorta di protettorato sul monastero?
Ma dal momento che alcuni rappresentanti della famiglia avevano intrapreso con discreto successo la carriera ecclesiastica, potrebbe darsi che lo stemma stesse piuttosto a significare una sorta di protettorato sul monastero?
- BrunaR
- Messaggi: 19
- Iscritto il: martedì 14 aprile 2009, 21:21
Re: Insegne in Valdinievole
BrunaR ha scritto:2)
Numero 2
Potrebbe ricollegarsi ai Lambardi di Maona (dei quali non conosco simboli identificativi), o essere una più antica versione dello stemma dei Malaspina, che dai Lambardi sembrano derivare?
- BrunaR
- Messaggi: 19
- Iscritto il: martedì 14 aprile 2009, 21:21
Re: Insegne in Valdinievole
Diamo il giusto merito a Cadwor di aver puntato sui Feroni
e potra' dirci dove ha preso le due foto lapidee che ha mostrato
--una priva di corona
--una con corona metallica aggiunta
( significativi di un prima e di un dopo )
Qualcuno piu' esperto di me in araldica potra' parlare della fattura della corona lapidea che aiuta nella datazione
I titoli nobiliari nella Toscana granducale non furono usati per lunghissimo tempo
Quindi sono "roba" abbastanza moderna
Visto che e' collocato all'esterno propenderei per un segno di patronato
A Non mi intendo sufficientemente di araldica , ma la fattura ed il degrado me lo fanno apparire non sufficientemente antico
B non conosco sufficientemente i Malaspina ma un dato e' certo :
l'araldica in Toscana viene introdotta intorno alla meta' tarda del secolo XII. Quindi prima si parla di eta' prearaldica ( priva di stemmi )
Lo Stemma di Ugo di Toscana di cui parla Dante Alighieri e' pura invenzione fuorviante
( Quello che campeggia nella "Badia" segue la stessa invenzione ed e' tardo )
Il medesimo per lo stemma dell'attonide Matilde morta nel 1115 ( stemma inesistente )
e potra' dirci dove ha preso le due foto lapidee che ha mostrato
--una priva di corona
--una con corona metallica aggiunta
( significativi di un prima e di un dopo )
Qualcuno piu' esperto di me in araldica potra' parlare della fattura della corona lapidea che aiuta nella datazione
I titoli nobiliari nella Toscana granducale non furono usati per lunghissimo tempo
Quindi sono "roba" abbastanza moderna
Visto che e' collocato all'esterno propenderei per un segno di patronato
Numero 2
Potrebbe ricollegarsi ai Lambardi di Maona (dei quali non conosco simboli identificativi), o essere una più antica versione dello stemma dei Malaspina, che dai Lambardi sembrano derivare?
A Non mi intendo sufficientemente di araldica , ma la fattura ed il degrado me lo fanno apparire non sufficientemente antico
B non conosco sufficientemente i Malaspina ma un dato e' certo :
l'araldica in Toscana viene introdotta intorno alla meta' tarda del secolo XII. Quindi prima si parla di eta' prearaldica ( priva di stemmi )
Lo Stemma di Ugo di Toscana di cui parla Dante Alighieri e' pura invenzione fuorviante
( Quello che campeggia nella "Badia" segue la stessa invenzione ed e' tardo )
Il medesimo per lo stemma dell'attonide Matilde morta nel 1115 ( stemma inesistente )
- pierluigic
- Messaggi: 1750
- Iscritto il: lunedì 5 settembre 2005, 22:40
- Località: la spezia >>>> pierluigi18faber@libero.it
Re: Insegne in Valdinievole
Niente prima e dopo
anche il manufatto senza corona in realta' ne era provvisto (di corona )
https://catalogo.beniculturali.it/detai ... 0900076708
Villa Feroni di Bellavista
NOTIZIE STORICO CRITICHE Assai piacevole questo manufatto piuttosto comune. E' databile alla fine del XVII secolo, assumendo come sicuro post-quem il 1673, anno in cui la proprietà fu acquistata da Francesco Feroni. In tale occasione gli venne concesso anche il titolo di marchese, di cui fu investito con diploma il 28 ottobre 1681, secondo quanto riporta lo Spreti. Sullo stemma era collocata la corona marchionale, pure in marmo, che attualmente, in pezzi, è posta su una mensola nel salone principale
https://catalogo.beniculturali.it/detai ... 0900157394
Via de' Serragli n. 8, Firenze (FI)
NOTIZIE STORICO CRITICHE Dalle schede di Carocci (1896) si ricava che il Palazzo su cui è posto questo stemma fu costruito tra il 1428 e 1450 quando era di proprietà dei Del Pugliese. La famiglia Feroni, a cui appartiene questo stemma, ebbe la proprietà del palazzo per successione dal 1778 e dette incarico all'architetto Zanobi del Rosso di riordinare la parte architettonica ed il giardino. Nel 1821 il palazzo fu acquistato dai Magnani. Lo stemma Feroni quindi dovrebbe risalire alla fine del secolo XVIII (1778), come del resto è confermato dal "ductus" compositivo e dalla fattura degli elementi decorativi. I Feroni costruendo questo palazzo incorporarono molte case e parte del Monastero di San Frediano
anche il manufatto senza corona in realta' ne era provvisto (di corona )
https://catalogo.beniculturali.it/detai ... 0900076708
Villa Feroni di Bellavista
NOTIZIE STORICO CRITICHE Assai piacevole questo manufatto piuttosto comune. E' databile alla fine del XVII secolo, assumendo come sicuro post-quem il 1673, anno in cui la proprietà fu acquistata da Francesco Feroni. In tale occasione gli venne concesso anche il titolo di marchese, di cui fu investito con diploma il 28 ottobre 1681, secondo quanto riporta lo Spreti. Sullo stemma era collocata la corona marchionale, pure in marmo, che attualmente, in pezzi, è posta su una mensola nel salone principale
https://catalogo.beniculturali.it/detai ... 0900157394
Via de' Serragli n. 8, Firenze (FI)
NOTIZIE STORICO CRITICHE Dalle schede di Carocci (1896) si ricava che il Palazzo su cui è posto questo stemma fu costruito tra il 1428 e 1450 quando era di proprietà dei Del Pugliese. La famiglia Feroni, a cui appartiene questo stemma, ebbe la proprietà del palazzo per successione dal 1778 e dette incarico all'architetto Zanobi del Rosso di riordinare la parte architettonica ed il giardino. Nel 1821 il palazzo fu acquistato dai Magnani. Lo stemma Feroni quindi dovrebbe risalire alla fine del secolo XVIII (1778), come del resto è confermato dal "ductus" compositivo e dalla fattura degli elementi decorativi. I Feroni costruendo questo palazzo incorporarono molte case e parte del Monastero di San Frediano
- pierluigic
- Messaggi: 1750
- Iscritto il: lunedì 5 settembre 2005, 22:40
- Località: la spezia >>>> pierluigi18faber@libero.it
Re: Insegne in Valdinievole
Una famiglia estinta ( estinta in questo ramo ! attenzione ! )
confluita in una famiglia che ha una storia del tutto diversa ( storicamente e geneticamente )
Una famiglia che ha una storia che e' un documento. Una storia che mostra uno dei tanti volti della nobilta' di Ancien regime
La parabola di una famiglia che ci fa leggere la STORIA come effettivamente va letta
Prezioso specchio di quei tempi
Nella fase di ascesa vi e' intraprendenza ed improntitudine mercantile ed imprenditoriale premiata con un forte arricchimento
Nella fase discendente :
l'abbandono dell'esercizio delle arti meccaniche e del commercio che ne avevano permesso l'ascesa
il frazionamento del patrimonio ,
le liti familiari
il confluire del patrimonio rimanente e del titolo in una famiglia del tutto diversa ( secondo i nostri canoni che ci legano al cognome paterno ) per via femminile
Interessante questa trasmigrazione del titolo marchionale
Probabilmente con le solite inconcludenti storie nobiliari questa vicenda sarebbe stata addolcita con fantasie che non ci avrebbero fatto capire piu' nulla del reale andamento dei fatti . Fortunatamente SIUSA ce la mostra senza fronzoli
.
confluita in una famiglia che ha una storia del tutto diversa ( storicamente e geneticamente )
Una famiglia che ha una storia che e' un documento. Una storia che mostra uno dei tanti volti della nobilta' di Ancien regime
La parabola di una famiglia che ci fa leggere la STORIA come effettivamente va letta
Prezioso specchio di quei tempi
Nella fase di ascesa vi e' intraprendenza ed improntitudine mercantile ed imprenditoriale premiata con un forte arricchimento
Nella fase discendente :
l'abbandono dell'esercizio delle arti meccaniche e del commercio che ne avevano permesso l'ascesa
il frazionamento del patrimonio ,
le liti familiari
il confluire del patrimonio rimanente e del titolo in una famiglia del tutto diversa ( secondo i nostri canoni che ci legano al cognome paterno ) per via femminile
Interessante questa trasmigrazione del titolo marchionale
Probabilmente con le solite inconcludenti storie nobiliari questa vicenda sarebbe stata addolcita con fantasie che non ci avrebbero fatto capire piu' nulla del reale andamento dei fatti . Fortunatamente SIUSA ce la mostra senza fronzoli
.
- pierluigic
- Messaggi: 1750
- Iscritto il: lunedì 5 settembre 2005, 22:40
- Località: la spezia >>>> pierluigi18faber@libero.it
11 messaggi
• Pagina 1 di 1
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 19 ospiti